La gestione dello stress: comprendere e controllare le reazioni dell’organismo
31 Lug 2025
Tempo di lettura: 6 minuti
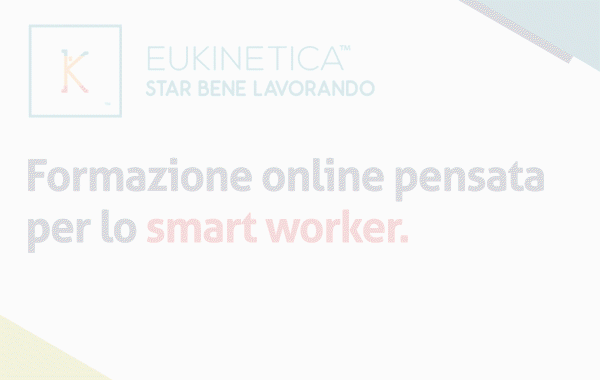

È fondamentale conoscere lo stress per gestirlo efficacemente, laddove sia possibile farlo. Una volta esaminate le sue caratteristiche, i sintomi e le circostanze in cui si manifesta, emerge un alleato prezioso per il suo controllo: la respirazione.
Capire la differenza tra le diverse tipologie di stress e i meccanismi che li sottendono è il primo passo per un benessere duraturo. Il nostro organismo è costantemente “acceso”, e la sfida consiste nel mantenere un’ottimale regolazione dello stato di tensione nervosa anche a riposo. Affrontare la giornata con la giusta energia e consapevolezza delle risposte del nostro corpo può fare la differenza tra un’esperienza positiva e una fonte di affaticamento e malessere.
Eustress e distress: il lato positivo e negativo dello stress
Non tutto lo stress viene per nuocere; è essenziale operare una distinzione preliminare.
Per vivere, infatti, abbiamo bisogno di un certo quantitativo di tensione che ci mantenga attivi per far fronte a necessità sia organiche (come respirare o digerire), sia quotidiane quali lo studio e il lavoro. Questo stato di tensione nervosa di base, paragonabile ai giri del motore di un’automobile in folle, ci consente di attivarci all’occorrenza senza doverci “accendere” completamente ogni volta.
A seconda di come rispondiamo agli impegni, lo stress può essere distinto in due tipologie: eustress e distress . L’eustress, o “stress positivo”, è la risposta dell’organismo a ciò che affrontiamo quotidianamente senza un sovraccarico emotivo. Quando gli impegni vengono affrontati con piacere e proattività, a fine giornata non si percepisce nemmeno la stanchezza, poiché la soddisfazione supera il dispendio energetico ed emotivo effettivo.
Al contrario, il distress, o “stress negativo”, si manifesta quando ciò che facciamo non è in linea con i nostri desideri o siamo coinvolti in carichi di lavoro inaspettati ed eccessivi . Questa condizione comporta una risposta dell’organismo più “smodata”, che lascia scorie come ansia, tristezza e sofferenza.
I meccanismi fisiologici dello stress sono affascinanti: in condizione di eustress, il corpo rilascia una quantità adeguata di cortisolo, che stimola il rilascio di glucosio, il carburante energetico per affrontare la giornata. In condizioni di distress, invece, la produzione di cortisolo si decuplica e viene supportata dalla secrezione di adrenalina e noradrenalina. Questi neurotrasmettitori predispongono l’organismo a una repentina risposta di “attacco o fuga”, accelerando la frequenza cardiaca, aumentando la gittata cardiaca e dilatando le vie aeree bronchiali, migliorando la reattività.
Stress acuto, intermittente e cronico: riconoscere le diverse manifestazioni

L’organismo è da sempre predisposto ad affrontare gli stati di stress acuto, caratterizzati da un evento stressante con inizio e fine ben precisi, e le cui tre fasi di risposta organica (allarme, resistenza, esaurimento) sono ben delimitate e non lasciano scorie difficili da smaltire. In passato, lo stress acuto era legato a condizioni di sopravvivenza (predatori o prede), con risposte di attacco o fuga che si esaurivano rapidamente.
La fase di allarme mobilita risorse (cortisolo, adrenalina, noradrenalina, glucosio), segue la fase di resistenza (durata dello stress) e infine la fase di esaurimento per tornare all’equilibrio. Un buon sonno solitamente permette un recupero completo. Oggi, gli stressor acuti possono essere infortuni, malattie passeggere, carichi di lavoro inaspettati o pericoli imminenti. Tuttavia, gli stressor sono sempre meno “materiali” e la risposta di “attacco o fuga” è spesso meno pertinente.
Lo stress intermittente ha le stesse caratteristiche dello stress acuto, ma si ripresenta a intervalli regolari. Esempi professionali includono i picchi di lavoro ciclici negli uffici contabili, mentre a livello personale si possono considerare le feste comandate che aumentano lo stress quotidiano fino alla loro conclusione.
Lo stress cronico è la tipologia più problematica per l’organismo. Avendo un inizio noto ma un termine sconosciuto, la fase di resistenza si protrae nel tempo, causando un progressivo esaurimento delle risorse e, a medio e lungo termine, stati di esaurimento psicofisico difficili da risolvere, che possono sfociare nella sindrome da burnout.

Il burnout è un processo graduale descritto in quattro fasi:
- fase dell’entusiasmo: la persona sacrifica tempo libero per il lavoro, con la convinzione irrealistica di un rapido successo.
- fase della stagnazione: delusione delle aspettative e adozione di un atteggiamento passivo e rinunciatario.
- fase della frustrazione: la persona si sente inutile e prova rabbia verso colleghi, superiori e utenti.
- fase del disimpegno: perdita totale dell’entusiasmo iniziale e distacco dal proprio lavoro.
I tre segnali inequivocabili del burnout sono: senso di esaurimento delle energie, ridotta efficacia professionale e aumento della distanza mentale dal proprio lavoro. Chi vive questa condizione difficilmente la risolve con il riposo e necessita di supporto psicologico o riabilitazione.
Sintomi e fattori di innesco dello stress: un quadro completo
Lo stress, nella sua manifestazione non degenerata, può colpire l’individuo con diverse tipologie di sintomi: fisici, cognitivi, comportamentali ed emozionali.
- Tra i sintomi fisici si annoverano: alterazione della respirazione fisiologica (toracica con necessità di sbuffare), tensioni muscolari (mani, spalle, collo, mandibola, glutei, schiena, bocca dello stomaco), mal di testa e capogiri, offuscamento della vista, acufeni, abbassamento delle difese immunitarie, reflusso gastroesofageo, formicolio alle mani, tachicardia, sudorazione delle mani e restless legs syndrome.
- I sintomi cognitivi includono: scarsa lucidità mentale, perdita dell’umorismo, sensibilità alle critiche, distorsioni della realtà, difficoltà a portare a termine i compiti, problemi nella presa di decisioni, difficoltà nel problem solving, distrazione, difficoltà a rimanere concentrati, lievi amnesie e preoccupazione costante.
- A livello comportamentale, si possono manifestare: digrignamento dei denti , compulsioni alimentari, atteggiamento critico verso gli altri, comportamenti prepotenti, alta resistenza ad andare al lavoro, difficoltà di relazione, demotivazione, assenteismo, tendenza all’isolamento e abuso di tv e social network.
- Infine, i sintomi emozionali comprendono: tensione, rabbia, irritabilità, infelicità, apatia, frustrazione, bassa autostima, senso di colpa e pianto frequente e immotivato.
Lo stress e la respirazione: il ruolo cruciale del diaframma
In caso di distress, la primissima funzione vitale che tende ad alterarsi è il respiro, che si agita, diventa più affannato e si localizza a livello toracico, predisponendoci all’attacco o alla fuga.
Il diaframma è il muscolo agonista della respirazione a riposo e in stato di quiete, con una forma a cupola che separa la cassa toracica dall’addome. In condizioni normali, i movimenti respiratori dovrebbero manifestarsi a livello dell’addome, che si espande nell’inspirazione e si sgonfia nell’espirazione. Il diaframma, contraendosi, si abbassa, creando una pressione polmonare negativa che favorisce l’ingresso dell’aria. La sua risalita e la conseguente espirazione sono promosse dal rilascio della forza elastica immagazzinata dagli addominali.
In condizioni di stress, la meccanica respiratoria si modifica per soddisfare l’aumentato fabbisogno di ossigeno necessario per lo sforzo imminente. Il diaframma, in tali circostanze, chiede aiuto ai muscoli accessori della respirazione (collo, spalle, scapole, torace) per espandere massimamente la cassa toracica, permettendo una maggiore immissione d’aria e veicolando più ossigeno nel sangue. Seguirà un’espirazione forzata per espellere più rapidamente l’anidride carbonica.
In caso di stress cronico, lo stato di allerta permanente porta il diaframma a rimanere in uno stato di rigidità permanente, ostacolando la sua funzione fisiologica. Chi vive una vita caratterizzata da stress manifesterà un’attività respiratoria prettamente toracica per vicariare l’azione del diaframma. Considerando che si compiono oltre 20.000 atti respiratori completi al giorno, questo comporta un irrigidimento di spalle, collo, scapole e torace, ridotta mobilità, dolorabilità articolare e, nei casi peggiori, protrusioni o ernie cervicali.
Oltre a questi risvolti muscolo-articolari, la disfunzione diaframmatica dovuta allo stress può provocare anche differenti patologie più serie.
Best practices per prendere il controllo della respirazione e ridurre lo stress

La respirazione è l’unica funzione vitale governata sia dal sistema nervoso autonomo (sna) che, per brevi momenti, dal sistema nervoso volontario (snv). L’inspirazione è la fase attiva e la risposta innata dell’organismo allo stressor, predisponendo all’attacco o fuga. L’espirazione, per contro, è la fase passiva e innesca i processi di rilassamento (rest and digest). È significativo che, al termine di un momento di stress, si tenda a fare un sospiro di sollievo.
Conoscendo questo aspetto, si ha la straordinaria opportunità di agire proprio su queste due fasi per riportare l’organismo a uno stato di quiete quando attaccare o fuggire non è la soluzione appropriata per gestire la circostanza.
Per allenarsi a riconoscere e controllare questi meccanismi, è importante praticare in condizioni di quiete, prolungando i tempi dell’espirazione rispetto a quelli dell’inspirazione.
Un esercizio pratico consiste nel rilevare la frequenza cardiaca (con cardiofrequenzimetro o palpando la carotide). Dopodiché, trovare una posizione comoda (sdraiata è l’ideale) e praticare la respirazione prolungando ogni fase di espirazione rispetto all’inspirazione, assicurandosi di espellere l’aria come se si dovesse appannare un vetro, con le labbra rilassate.
Al termine dell’esperienza, rilevare nuovamente i battiti per confrontarli: una riduzione, se l’esperienza non ha generato disagio, indicherà un effetto positivo.
Gestire lo stress è un’abilità che si può apprendere. Integrare la consapevolezza della respirazione e le best practices nella routine quotidiana può trasformare radicalmente il proprio benessere.
Per approfondire queste tecniche e acquisire strumenti concreti per il controllo dello stress, Eukinetica offre corsi dedicati alla salute dell’organismo e alla gestione dello stress per il benessere aziendale.
Scopri come migliorare la salute e la produttività dei tuoi collaboratori, contattaci per una richiedere consulenza personalizzata sui nostri corsi.
Articolo a cura di Giovanni Castellani, Training Manager e Partner di Eukinetica.

